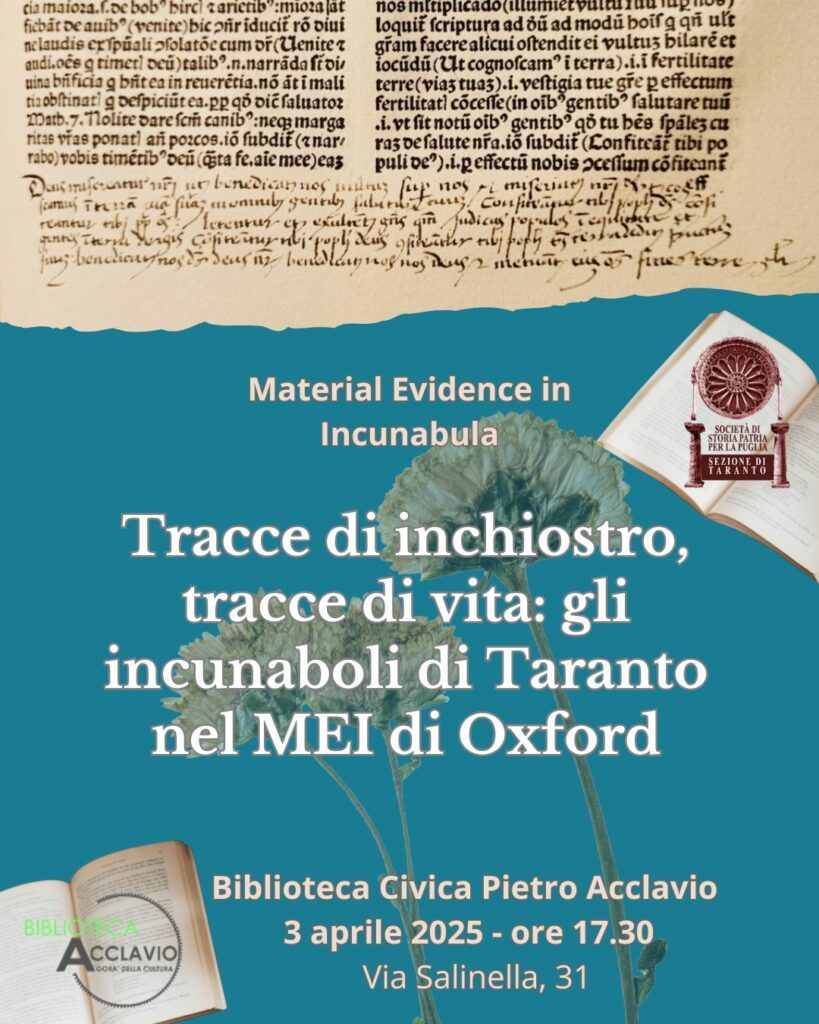
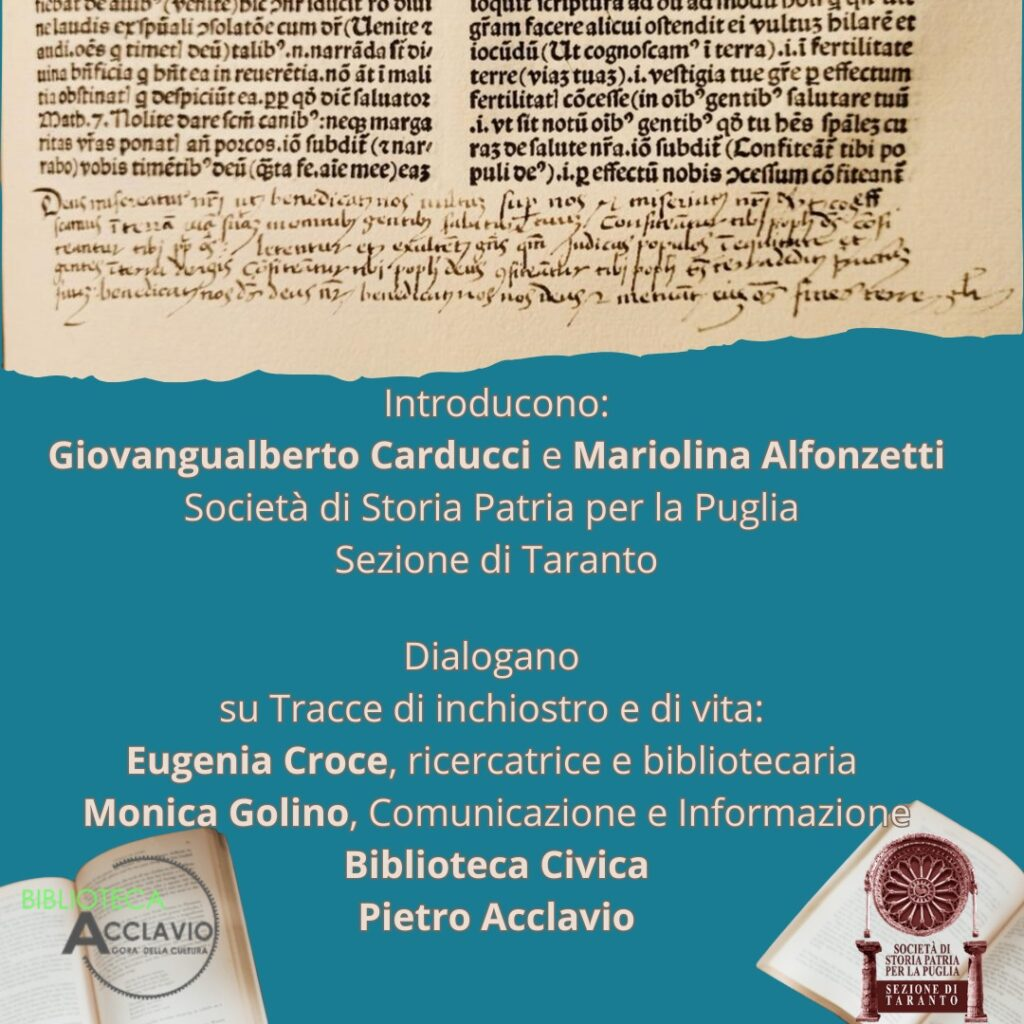
https://buonasera24.itevento/cultura-e-spettacoli/885325/incunaboli-capsule-del-tempo.html
Una bella serata all’insegna della cultura, quella vera, si è tenuta giovedì 3 aprile, a partire dalle ore 17:30, presso l’agorà della Civica Biblioteca “Pietro Acclavio”.
L’iniziativa, promossa dalla Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Taranto, ha offerto un’occasione unica per approfondire la conoscenza degli incunaboli conservati nella Biblioteca Civica Pietro Acclavio e nella Biblioteca Arcivescovile Giuseppe Capecelatro.
Protagoniste due studiose di valore, Eugenia Croce (archivista-ricercatrice e bibliotecaria) e Monica Golino (giornalista e professionista della comunicazione e informazione), entrambe dipendenti del Comune di Taranto.
Dopo i saluti del presidente prof. Gualberto Carducci, è intervenuta Mariolina Alfonzetti, la quale ha introdotto l’argomento “Tracce di inchiostro, tracce di vita: gli incunaboli di Taranto nel MEI di Oxford”, ed ha presentato le due protagoniste. Eugenia Croce, che ha svolto il lavoro sugli incunaboli di Taranto, conversando con Monica Golino, ha molto brillantemente svelato numerose curiosità che raccontano la storia di queste preziose opere. Su di esse – ha spiegato la relatrice – le annotazioni manoscritte (note di possesso, decorazioni, legature, postille, timbri e molto altro), lasciate nel corso del tempo dai lettori, attestano il dialogo intercorso con il testo, l’intensità e la durata della lettura nonché la personalità del postillatore.
Lo studio di questi incunaboli è stato integrato in un database collegato all’Incunabula Short Title Catalogue della British Library, nell’ambito del progetto oxoniense “Material Evidence in Incunabula” (MEI), ideato e coordinato da Cristina Dondi. Questo progetto mira a raccogliere tutti i dati esemplari delle edizioni del XV secolo.
Durante l’incontro sono intervenuti due soci della Società di Storia Patria per la Puglia, Josè Minervini (poetessa, scrittrice ed attuale presidente della Società “Dante Alighieri” sez. di Taranto) ed Antonio Basile, (già docente di Antropologia culturale e Antropologia delle società complesse nell’Accademia di belle arti di Lecce e direttore scientifico dal 2020 al 2023 del Civico museo etnografico Alfredo Majorano di Taranto) i quali si sono soffermati sull’importanza degli incunaboli nel X e XI secolo, periodo in cui i monaci, secondo una usanza che risaliva alla tradizione greca erano soliti trascrivere su quelle preziose pagine delle maledizioni al fine di distoglierli dal compiere un sacrilego furto.
I libri avevano un valore altissimo. Innanzitutto per la difficoltà della loro riproducibilità e anche per la preziosità dei volumi che venivano confezionati. A darcene un’idea è il benedettino Lupo di Ferières (IX sec.), un precursore dell’umanesimo per la passione per i libri che lo animava, il quale in una lettera a Incmaro, vescovo di Reims, scrive: «Ho avuto paura a inviarti il commentario di Beda sull’apostolo in accordo con le opere di Agostino perché il libro è tanto grande che non può essere nascosto nel petto né una bisaccia è sufficiente per contenerlo. E se l’una o l’altra cosa fosse possibile, ci sarebbe da temere di incontrare bande di malintenzionati la cui rapacità sarebbe accesa senza dubbio dalla bellezza del codice e così il libro andrebbe perduto per me e per te. Perciò senza rischi io stesso ti consegnerò il predetto volume appena, se Dio vuole, ci potremo incontrare in un posto al sicuro» (Epistola 76, PL 119,536-537).
Il furto dei libri, che attraversa quasi senza eccezioni tutta l’antichità, è una mala pianta che infesta non solo il mondo pagano ma si insinua anche tra le prime comunità cristiane. Dal punto di vista formale la più antica maledizione di cui vi è traccia in occidente è quella che accompagna la donazione di alcuni beni fatta da Theodetrude all’abbazia di Saint-Denys. La charta porta la data del 627 (anno 43° del regno di Clotario II). Con riferimento ai libri invece dal punto di vista cronologico la più antica è quella apposta su un manoscritto dell’VIII secolo dell’abbazia benedettina di san Medardo di Soissons che dice nella chiusa finale:Se qualcuno tenterà di sottrarre questo libro, non dubiti che finirà sotto il giudizio di Dio e di san Medardo.
Quella, citata in precedenza, dell’abbazia di san Medardo di Soissons è una formula piuttosto diffusa. Su un codice «con una scrittura a linee lunghe dell’VIII sec.», contenente degli estratti di opere di san Gregorio Magno, sul primo foglio un’iscrizione ricordava che il volume apparteneva all’abbazia benedettina di Fluery-sur-Loire e minacciava severamente chi avesse avuto l’intenzione di sottrarre il libro:Questo è un libro del cenobio di Fleury dell’abate san Benedetto; se qualcuno in mala fede lo avrà asportato per non restituirlo, riceva la dannazione insieme a Giuda il traditore, ad Anna, Caifa e Pilato. Amen
Le formulazioni sono particolarmente varie, e, spesso, coesistono con delle clausole penali.
Si riportano altri ammonimenti citati dai due ospiti.
“Questo libro è dello monastero di Sancto Benedetto sito fuori della porta appinti della cripta [sic] di Firenze dell’ordine dell’eremo di Camaldoli sotto la regola di sancto Benedetto. Chilla in prestanza lo renda e guardilo da fanciugli e da lucerna”.
L’autore è il bibliotecario del monastero di San Benedetto a Porta Pinti di Firenze che invita chi dovesse prendere in prestito l’esemplare della Commedia, Firenze, Nicolò di Lorenzo, 1481 (oggi in collezione privata), a restituirlo e a guardarlo da due dei peggiori nemici che mai un libro possa incontrare.
Si quis hunc furto rapiat libellum nec suo reddat domino petenti maxima poena contritus ille carcere dignus” (Se qualcuno asporterà con furto questo libretto e non lo restituirà al legittimo proprietario che lo reclama, sia sottoposto alla pena più severa e sia degno del carcere). Si legge su un De civitate dei, stampato a Venezia il 2 ottobre 1475, oggi presso la Biblioteca Universitaria di Pavia.
“Ve tibi qui rapida librum furabere palma Nam videt altisonans omnia gesta deus Furaces quicumque manus ad furta paratis Huiusce memores vos decet esse loci. Si quis erit qui me minibus furetur aduncis Reddat ne tetras possit adire domus” (Guai a te che ruberai questo libro con mano rapace: se ci sarà qualcuno che mi ruberà con adunche mani, mi restituisca, per non rischiare di precipitare nella tenebrosa).
Se, nella documentazione bizantina, le clausole assumono un linguaggio neotestamentario, con riferimento alle pene rivolte contro coloro i quali hanno crocifisso Gesù o agli eretici, nelle carte occidentali ci si richiama specialmente ai reprobi dell’antico Testamento. In Italia meridionale e in Sicilia, dove convivono popolazioni greche e latine e organizzazioni politiche bizantine e occidentali, il panorama della clausole di anatema risente degli apporti e delle influenze provenienti da entrambi i contesti religiosi, culturali e ideologici.
In Occidente, la frequenza dell’anatema o della maledizione come clausola penale nei documenti raggiunge il massimo durante i secoli X e XI. Little e Zimmermann giustamente ricollegano tale picco con la debolezza e il frazionamento dei poteri pubblici che contraddistinguono questo periodo.








